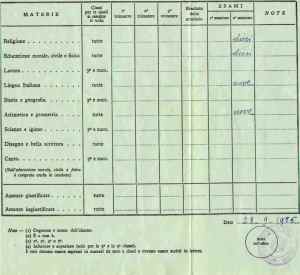Leggendo la oramai famosa storia della studentessa bendata durante un’interrogazione in didattica a distanza (Dad), ho pensato alla docente ed a cosa ha perso.
Perché un gesto del genere, rompe, drammaticamente, ogni possibilità relazionale, sana, con gli studenti. E’ l’interruzione di ciò che di più caro c’è dentro il rapporto maestro/allievo, la frantumazione della relazione formativa come atto d’amore. Perché insegnare è anche questo si, un atto d’amore.
Quello che è successo non può che indebolire ogni forma possibile di apprendimento futuro. E non importa se i genitori siano o meno d’accordo con la scelta, rimane, per me, un atto violento, di prevaricazione, quello che in termini tecnici si chiama, per alcuni i ruoli di cura: “abuso di posizione dominante”. E attenzione, non importa nemmeno l’accordo con la studentessa. Un docente, un formatore, un educatore non dovrebbe accettare, mai, di porre i propri formandi in una condizione del genere. Punto.
Ho letto molti post e commenti su questa storia e mi son preso il tempo per rifletterci. Mi son preso il tempo per ragionarci perché non mi interessa puntare il dito sulla docente in questione. A giudicare il suo operato ci son già il dirigente scolastico e chi si occuperà di indagare su ciò che è successo. Io faccio altro nella vita e mi interessa porre l’attenzione sulle possibili radici e sulle conseguenze di un gesto del genere. Soprattutto da un punto di vista educativo.
Il problema, quando si decide di bendare una studentessa sta, secondo me, più sul piano etico, nell’idea di rapporto tra esseri umani che si ha in testa. Poi probabilmente ci son di mezzo anche alcune problematiche metodologiche e connesse con l’idea di didattica che si ha in mente, ma il problema è, secondo me, connesso con la propria formazione umana, prima che professionale.
Ha ragione, in questa direzione, chi si chiede cosa farebbe, in presenza, una docente che fa una scelta del genere, perché il problema non è mica la Dad, che ha solo reso visibile ciò che avviene, a volte, all’interno delle relazioni tra studenti e docenti. In cui non sempre le vittime sono gli adulti, prevaricati dai ragazzi.
Bendando una ragazza mentre la interroghi, danneggi il tuo rapporto con gli studenti (tutti, anche chi ha solo osservato la scena e magari ha riso dietro lo schermo). Fai, soprattutto, un danno al tuo ruolo, perché dopo una scena del genere perdi di credibilità, agli occhi della studentessa e forse anche agli occhi di compagni e compagne di classe. Bendandola danneggi la studentessa e il suo rapporto con l’apprendimento, stravolgendone completamente il senso e il valore. Stravolgi, inoltre, completamente il senso più prezioso dell’azione di valutazione.
Bendando una studentessa per interrogarla in Dad (didattica a distanza), metti sul piatto il tuo limite rispetto alla capacità di essere in contatto con l’altro e con le sue emozioni e questo è un problema grosso, se ti occupi di formazione. In questo senso ciò che è avvenuto mostra un problema decisamente più generale, una crepa tipica di chi smette di interrogarsi su ciò che fa. Un problema comune a tanti adulti che formano e che educano, non solo ai docenti, ovviamente.
Sia chiaro, dato che non voglio essere frainteso. A scuola (e negli ambiti formativi) ci sono, per fortuna, anche tantissimi docenti e formatori eccezionali, preparati e attenti. Adulti che continuano a studiare e a interrogarsi rispetto al senso del proprio intervento.
Nei ultimi tempi, parlando di insegnamento, mi capita sempre più spesso di percepire una sovrapposizione tra la capacità di passare una nozione e l’insegnamento stesso, che però necessità anche di molto altro.
Formare è una funzione che si porta dietro alcune fatiche, necessarie per far bene il proprio lavoro. Una delle fatiche più importanti è connessa con la capacità empatico/relazionale. Fatica che non tutti son disponibili a fare e che spiega, almeno in parte, perché alcuni docenti e formatori preferiscano occuparsi solo del passaggio della parte nozionistica. Dimenticandosi così che la didattica non può essere scorporata dalla capacità relazionale, se non con il rischio di invalidare e/o indebolire l’apprendimento stesso.
Parlo di fatica perché so anche quanto sia complesso, a volte, tenere insieme la costruzione della relazione educativa e il passaggio di conoscenze specifiche. Ma da qui non si scappa, perché è proprio dalla connessione di questi due aspetti che deriva il tipo e la forza dell’apprendimento che produciamo.
E’ l’antico binomio educazione e didattica, che si rompe, quando bendi una studentessa, come se il bisogno di “valutare” gli apprendimenti potesse passare sopra ad ogni cosa, asfaltando anche la relazione stessa con la ragazza. Si lede così, insieme alla dignità di una studentessa anche la dignità di uno dei lavori più importanti e delicati del mondo.
Un abbraccio a tutti i ragazzi e le ragazze, vittime invisibili di questa pandemia e a tutti quei docenti, formatori ed educatori che quando han visto la ragazza bendata hanno avuto un tuffo al cuore, perché han percepito che si trovavano davanti a qualcosa che non dovrebbe capitare mai, in una scuola, senza sé e senza ma.
Un grazie a Licia Coppo e Eva Pigliapoco, che mi hanno stimolato, a loro insaputa, questa riflessione.




























 18 anni è l’età dei sogni è l’età del desiderio, che si fa concreto, di spiccare il volo.
18 anni è l’età dei sogni è l’età del desiderio, che si fa concreto, di spiccare il volo.




 “Se non fossi stato scout penserei che un foulard sia solo un semplice fazzoletto alla francese e che il nodo piano sia solo un nodo da fare più lentamente degli altri. Se non fossi stato scout crederei ancora che uno zaino non può contenere i ricordi di una vita e che un guidone sia solo una guida turistica più importante delle altre. Se non fossi stato scout saprei ancora vestirmi e non andrei girando in pantaloncini in pieno inverno, rispondendo a chiunque mi dica “ma dove vai vestito cosi”, con un’ espressione al limite tra una smorfia di dolore ed un sorriso: “no, ma non fa così freddo”.Se non fossi stato scout non farei la figura dello spazzino ogni volta che vedo una cartaccia a terra e non avrei le tasche piene di fogli e bustine di plastica. Se non fossi stato scout crederei che le ore 6:00 di mattina siano solo una trovata degli orologiai per riempire gli spazi vuoti di un orologio, ma non avrei idea dell’infinito che si spalanca all’orizzonte quando il sole torna nel cielo dopo una notte d’amore con la luna. Se non fossi stato scout non avrei mai conosciuto il mio più grande amore, la mia chitarra, ma avrei risparmiato i timpani dei miei fratelli del reparto durante i campeggi insieme. Se non fossi stato scout avrei passato l’estate al mare, ignorando il fatto che solo la montagna ti fa comprendere “il senso della tua piccolezza e la dimensione infinita della tua anima”. Se non fossi stato scout penserei ad arrivare prima degli altri durante un’escursione, ed ignorerei totalmente la bellezza di un sorriso che ti regala una compagna in difficoltà quando la aiuti ad andare avanti. Se non fossi stato scout me ne starei a casa al caldo quando fuori piove, ma non avrei mai ascoltato la voce della pioggia sulle foglie degli alberi ed il profumo del sottobosco dopo un temporale. Se non fossi stato scout avrei tanti amici in meno, ma in particolar modo non avrei mai conosciuto fratello fuoco che ti fa compagnia nelle notti più dure, quando la paura di non farcela ti assale la mente e le forze vanno sempre di più a svanire. Se non fossi stato scout crederei che le storie di ragazzi che, con zaino in spalla, camminano per giorni e giorni macinando decine di chilometri in montagna, siano solo leggendarie montature cinematografiche. Se non fossi stato scout non avrei mai combattuto contro Shere Kan e penserei davvero che una pantera ed un orso non possano crescere un cucciolo d’uomo. Se non fossi stato scout non avrei mai scalato una montagna con uno zaino di 10 kg in spalla, ma non saprei che quando sei su, il vento può affogare tutti i tuoi pensieri, se ne bevi abbastanza. Se non fossi stato scout non avrei mai passato notti insonni in una tenda con una pietra a tormentarmi dietro la schiena, ma non mi sarei mai divertito a nascondermi, nelle tende degli altri, dai capi. Se non fossi stato scout, la mattina, invece di fare ginnastica, sarei stato nel letto a dormire, ma non avrei mai “fatto quattro salti in su e mosso un po’ la testa in giù”. Se non fossi stato scout non avrei mai dormito all’addiaccio sobbalzando dal sacco a pelo ad ogni piccolo rumore, ma non avrei mai confidato tutti i miei segreti alle stelle e giocato ad afferrare la luna. Se non fossi stato scout non mi sarei mai innamorato in route, e non avrei mai passato le notti a cercare il coraggio di parlarle, il giorno dopo. Se non fossi stato scout non sarei un uomo con il cuore di un Lupetto, i sogni di un Esploratore e la coscienza di un Rover…”
“Se non fossi stato scout penserei che un foulard sia solo un semplice fazzoletto alla francese e che il nodo piano sia solo un nodo da fare più lentamente degli altri. Se non fossi stato scout crederei ancora che uno zaino non può contenere i ricordi di una vita e che un guidone sia solo una guida turistica più importante delle altre. Se non fossi stato scout saprei ancora vestirmi e non andrei girando in pantaloncini in pieno inverno, rispondendo a chiunque mi dica “ma dove vai vestito cosi”, con un’ espressione al limite tra una smorfia di dolore ed un sorriso: “no, ma non fa così freddo”.Se non fossi stato scout non farei la figura dello spazzino ogni volta che vedo una cartaccia a terra e non avrei le tasche piene di fogli e bustine di plastica. Se non fossi stato scout crederei che le ore 6:00 di mattina siano solo una trovata degli orologiai per riempire gli spazi vuoti di un orologio, ma non avrei idea dell’infinito che si spalanca all’orizzonte quando il sole torna nel cielo dopo una notte d’amore con la luna. Se non fossi stato scout non avrei mai conosciuto il mio più grande amore, la mia chitarra, ma avrei risparmiato i timpani dei miei fratelli del reparto durante i campeggi insieme. Se non fossi stato scout avrei passato l’estate al mare, ignorando il fatto che solo la montagna ti fa comprendere “il senso della tua piccolezza e la dimensione infinita della tua anima”. Se non fossi stato scout penserei ad arrivare prima degli altri durante un’escursione, ed ignorerei totalmente la bellezza di un sorriso che ti regala una compagna in difficoltà quando la aiuti ad andare avanti. Se non fossi stato scout me ne starei a casa al caldo quando fuori piove, ma non avrei mai ascoltato la voce della pioggia sulle foglie degli alberi ed il profumo del sottobosco dopo un temporale. Se non fossi stato scout avrei tanti amici in meno, ma in particolar modo non avrei mai conosciuto fratello fuoco che ti fa compagnia nelle notti più dure, quando la paura di non farcela ti assale la mente e le forze vanno sempre di più a svanire. Se non fossi stato scout crederei che le storie di ragazzi che, con zaino in spalla, camminano per giorni e giorni macinando decine di chilometri in montagna, siano solo leggendarie montature cinematografiche. Se non fossi stato scout non avrei mai combattuto contro Shere Kan e penserei davvero che una pantera ed un orso non possano crescere un cucciolo d’uomo. Se non fossi stato scout non avrei mai scalato una montagna con uno zaino di 10 kg in spalla, ma non saprei che quando sei su, il vento può affogare tutti i tuoi pensieri, se ne bevi abbastanza. Se non fossi stato scout non avrei mai passato notti insonni in una tenda con una pietra a tormentarmi dietro la schiena, ma non mi sarei mai divertito a nascondermi, nelle tende degli altri, dai capi. Se non fossi stato scout, la mattina, invece di fare ginnastica, sarei stato nel letto a dormire, ma non avrei mai “fatto quattro salti in su e mosso un po’ la testa in giù”. Se non fossi stato scout non avrei mai dormito all’addiaccio sobbalzando dal sacco a pelo ad ogni piccolo rumore, ma non avrei mai confidato tutti i miei segreti alle stelle e giocato ad afferrare la luna. Se non fossi stato scout non mi sarei mai innamorato in route, e non avrei mai passato le notti a cercare il coraggio di parlarle, il giorno dopo. Se non fossi stato scout non sarei un uomo con il cuore di un Lupetto, i sogni di un Esploratore e la coscienza di un Rover…”


 Intendiamoci.
Intendiamoci.


 Un ringraziamento particolare va a Giulio, Roberta e Lele. Perché incontrarli è stato per me molto importante. Forse più di quanto loro possano pensare.
Un ringraziamento particolare va a Giulio, Roberta e Lele. Perché incontrarli è stato per me molto importante. Forse più di quanto loro possano pensare. Il 13 novembre 2015 rimarrà per molto tempo nella mente di tutti gli europei, rimarrà nella mia, che ho tremato per la sorte di due persone care. Rimarrà nella mia testa perché una volta saputo che erano salve, mi son sentito in colpa, perché ero felice. “Come si puoi essere felice”, mi son chiesto, “non pensi agli altri?”. In quel momento non ci ho pensato, mi è bastato quello. Poi ragionandoci, mi son anche detto che in fondo è ciò che ci succede continuamente quando leggiamo le orrende notizie che i media ci narrano. Notizie che solo la lontananza può rendere sostenibili, altrimenti il dolore dei continui drammi a cui assistiamo potrebbe distruggerci.
Il 13 novembre 2015 rimarrà per molto tempo nella mente di tutti gli europei, rimarrà nella mia, che ho tremato per la sorte di due persone care. Rimarrà nella mia testa perché una volta saputo che erano salve, mi son sentito in colpa, perché ero felice. “Come si puoi essere felice”, mi son chiesto, “non pensi agli altri?”. In quel momento non ci ho pensato, mi è bastato quello. Poi ragionandoci, mi son anche detto che in fondo è ciò che ci succede continuamente quando leggiamo le orrende notizie che i media ci narrano. Notizie che solo la lontananza può rendere sostenibili, altrimenti il dolore dei continui drammi a cui assistiamo potrebbe distruggerci.



 Lo sai, nel tuo lavoro può succedere. L’hai detto non più di due settimane fa in equipe che il nostro lavoro riguarda la vita e la morte. Sembrava melodramma, occhi perplessi o increduli, ma volevi dire che il lavoro che si fa è importante, è serio, bisogna farlo con cura, anche quando ridi insieme ai ragazzi o giochi a pallone. Lo sai, ma non ti va sempre giù: titoli dei giornali, solo se quel giorno qualcosa va storto. Ma dei giorni prima a corrergli dietro te ne ricordi ormai a migliaia, e te ne ricordi solo tu; in piscina anche se non ti va, a farti mordere, a ridere a piangere, con le vittorie, le sconfitte. Talvolta pensi a quello in tv con la battuta sempre pronta, a quello che è bravo con una palla o è sempre al posto giusto che guadagna in un giorno, un anno del tuo lavoro. Ma te lo sei scelto. Se non sei vecchio, magari hai pure studiato per quello. Se non sei stato fortunato magari hai visto tuo padre piegarsi negli anni, a fare l’operaio, mai a cercare un riconoscimento. La paga a fine mese e basta così. E ti sei chiesto perché l’etica del lavoro è più praticata, dai 1500€ in giù. Ma oramai sei stato educato così, che ci vuoi fare. E ci credi, che ogni vita è degna di essere vissuta se insieme rendiamo la vita degna, anche quando è al limite, anche quando non parla, o dice cose strane, non muove muscolo. E credi che nel tuo lavoro ci sia una responsabilità nel renderla degna, insieme alla fatica di tante mamme e papà che non vogliono, non possono arrendersi.
Lo sai, nel tuo lavoro può succedere. L’hai detto non più di due settimane fa in equipe che il nostro lavoro riguarda la vita e la morte. Sembrava melodramma, occhi perplessi o increduli, ma volevi dire che il lavoro che si fa è importante, è serio, bisogna farlo con cura, anche quando ridi insieme ai ragazzi o giochi a pallone. Lo sai, ma non ti va sempre giù: titoli dei giornali, solo se quel giorno qualcosa va storto. Ma dei giorni prima a corrergli dietro te ne ricordi ormai a migliaia, e te ne ricordi solo tu; in piscina anche se non ti va, a farti mordere, a ridere a piangere, con le vittorie, le sconfitte. Talvolta pensi a quello in tv con la battuta sempre pronta, a quello che è bravo con una palla o è sempre al posto giusto che guadagna in un giorno, un anno del tuo lavoro. Ma te lo sei scelto. Se non sei vecchio, magari hai pure studiato per quello. Se non sei stato fortunato magari hai visto tuo padre piegarsi negli anni, a fare l’operaio, mai a cercare un riconoscimento. La paga a fine mese e basta così. E ti sei chiesto perché l’etica del lavoro è più praticata, dai 1500€ in giù. Ma oramai sei stato educato così, che ci vuoi fare. E ci credi, che ogni vita è degna di essere vissuta se insieme rendiamo la vita degna, anche quando è al limite, anche quando non parla, o dice cose strane, non muove muscolo. E credi che nel tuo lavoro ci sia una responsabilità nel renderla degna, insieme alla fatica di tante mamme e papà che non vogliono, non possono arrendersi.





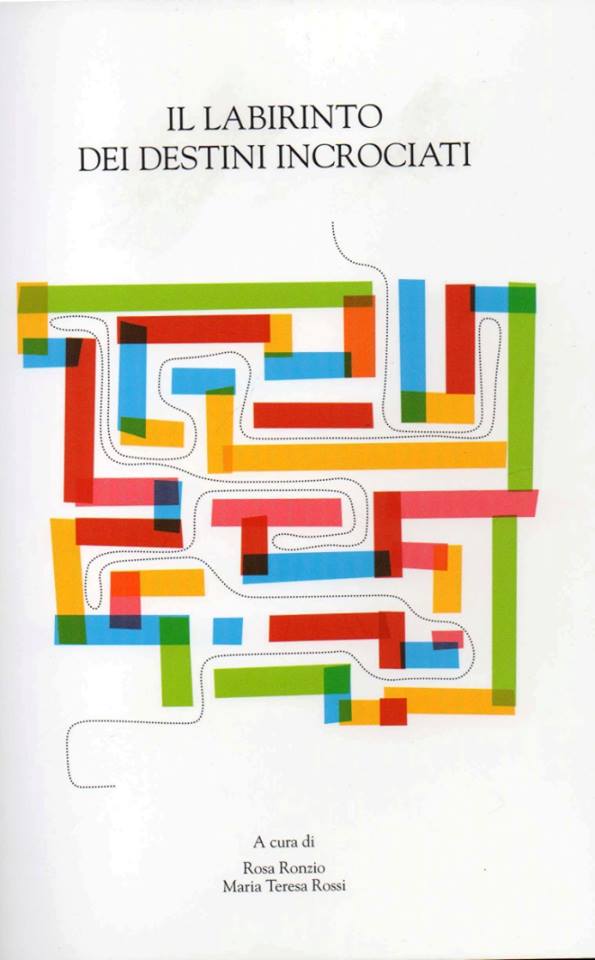















 In vista della seconda
In vista della seconda